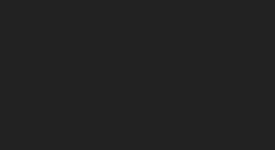|
 |
Fino al secondo dopoguerra, l’accesso all’istruzione in Italia era profondamente selettivo. La scuola dell’obbligo era formalmente gratuita già dalla Legge Coppino del 1877 (che rese obbligatoria l’istruzione elementare), ma i costi indiretti, libri, materiali, abbigliamento e trasporti, costituivano un ostacolo sostanziale per le famiglie povere. L’istruzione era considerata più un privilegio che un diritto, e lo Stato si limitava a garantire la cornice formale. Solo alcune categorie protette (orfani, figli di mutilati di guerra, poveri certificati) potevano accedere a forme di sostegno pubblico, erogate in genere da enti locali o associazioni caritatevoli. Il concetto di “sussidio scolastico” come strumento generalizzato era praticamente assente. Con l’approvazione della Costituzione del 1948, l’articolo 34 sancì che «la scuola è aperta a tutti» e che «l’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita». Negli anni ’50 e ’60, lo Stato iniziò a concepire l’istruzione pubblica come parte integrante del welfare. Nacquero i primi veri sussidi scolastici statali, legati al reddito, e si iniziarono a fornire libri gratuiti per le scuole elementari. La Legge 719/1964 fu il primo rimedio organico in tal senso, istituendo la fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni della scuola elementare. Si trattava però di un modello ancora centralizzato e cartaceo: le scuole ordinavano i testi in anticipo e li consegnavano alle famiglie all’inizio dell’anno scolastico. Durante il periodo del riformismo scolastico, si rafforzarono gli strumenti di supporto. Infatti, le Regioni e i Comuni cominciarono a erogare borse di studio, buoni libro, sussidi per trasporti e con la legge 517/1977 (che avviò l’inclusione degli alunni con disabilità) rafforzò anche il concetto di eguaglianza sostanziale nel diritto allo studio. Perciò, nacquero i libri in comodato d’uso (soprattutto in scuole medie e superiori), e le borse di studio nazionali per merito e reddito (Legge 62/2000). Tuttavia, la gestione rimaneva frammentata e diversificata, con molte differenze tra territori e forti ritardi amministrativi. Con l’introduzione dell’autonomia scolastica (Legge 59/1997) e la riforma del Titolo V della Costituzione (2001), la competenza in materia di diritto allo studio venne decentrata: alle Regioni spettava la programmazione e ai Comuni l’attuazione delle misure. In questo contesto nasce la cedola libraria: uno strumento introdotto per la scuola primaria, che permetteva ai genitori di ritirare gratuitamente i libri di testo presso librerie convenzionate, senza passare dalla scuola. Ogni Comune definiva la propria modalità, in forma cartacea. L’obiettivo era semplificare e responsabilizzare le famiglie, evitando sprechi e promuovendo il coinvolgimento del territorio (es. piccole librerie). Negli anni post-crisi del 2008, la spesa pubblica per l’istruzione è rimasta sotto la media UE. Molte famiglie hanno visto aumentare le spese scolastiche non coperte da sussidi, mentre le Regioni hanno cercato di ampliare gli strumenti disponibili con buoni digitali regionali (es. il Piemonte, la Lombardia ed il Lazio) con sistemi informatizzati per la richiesta e gestione online della cedola, sperimentando i libri digitali o misti, con poco impatto reale. Nel frattempo, le diseguaglianze educative sono aumentate, specie nelle aree periferiche e per le famiglie con background migratorio o redditi bassi. Peraltro, con la pandemia da COVID-19 (2020), è esplosa la questione della povertà educativa. Il sussidio scolastico si è evoluto per rispondere ad esigenze di digital divide (con bonus per device e connessioni) e potenziamento delle piattaforme per la cedola digitale, soprattutto nei grandi Comuni (es. Roma e Milano). Roma Capitale, ad esempio, ha reso la cedola libraria completamente digitale, consentendo alle famiglie di scegliere il fornitore online o in libreria, migliorando l’efficienza e la trasparenza. Oggi, lo strumento è ben rodato, ma persistono problemi sulla disomogeneità territoriale: i Comuni gestiscono in modo diverso cedole, bonus e sussidi, ed alcune esclusioniper i non residenti perché molte famiglie vivono in Comuni limitrofi, ma studiano in città e restano escluse come le famiglie con scarsa alfabetizzazione digitale o linguistica. L’evoluzione del sussidio scolastico, e in particolare della cedola libraria, è il riflesso di una tensione costante: tra universalismo e selettività, tra centralizzazione e autonomia, tra diritto dichiarato e accesso concreto. Il passaggio al digitale è una tappa necessaria, ma non sufficiente. Finché il diritto allo studio continuerà a essere condizionato dal reddito, dalla residenza o dalla capacità di orientarsi nella burocrazia, nessuna cedola, per quanto moderna, potrà colmare il divario. Per questo, il futuro dei sussidi scolastici dovrà essere ripensato non solo come aiuto economico, ma come leva strutturale per l’inclusione, l’equità e la giustizia educativa.