
Milano Summer schoool
Written by Osservatore MeneghinoDa oggi è pubblicata sul sito del Comune di Milano la mappa georeferenziata della Milano Summer school, iniziativa dell’Amministrazione per raccogliere l’offerta cittadina di attività ludico-ricreative ..
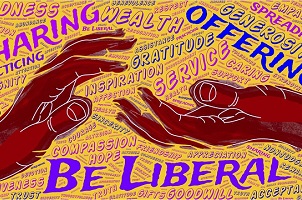
Liberali, che intolleranti
Written by Osservatore MeneghinoLiberali, che intolleranti. C’è un malato nella politica italiana. Non è il solo, anzi. In giro ci sono proprio degli zombie, defunti imbalsamati, come comunismo, socialismo, azionismo, sindacalismo, ..



