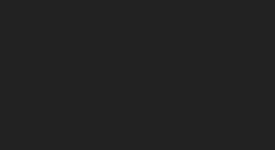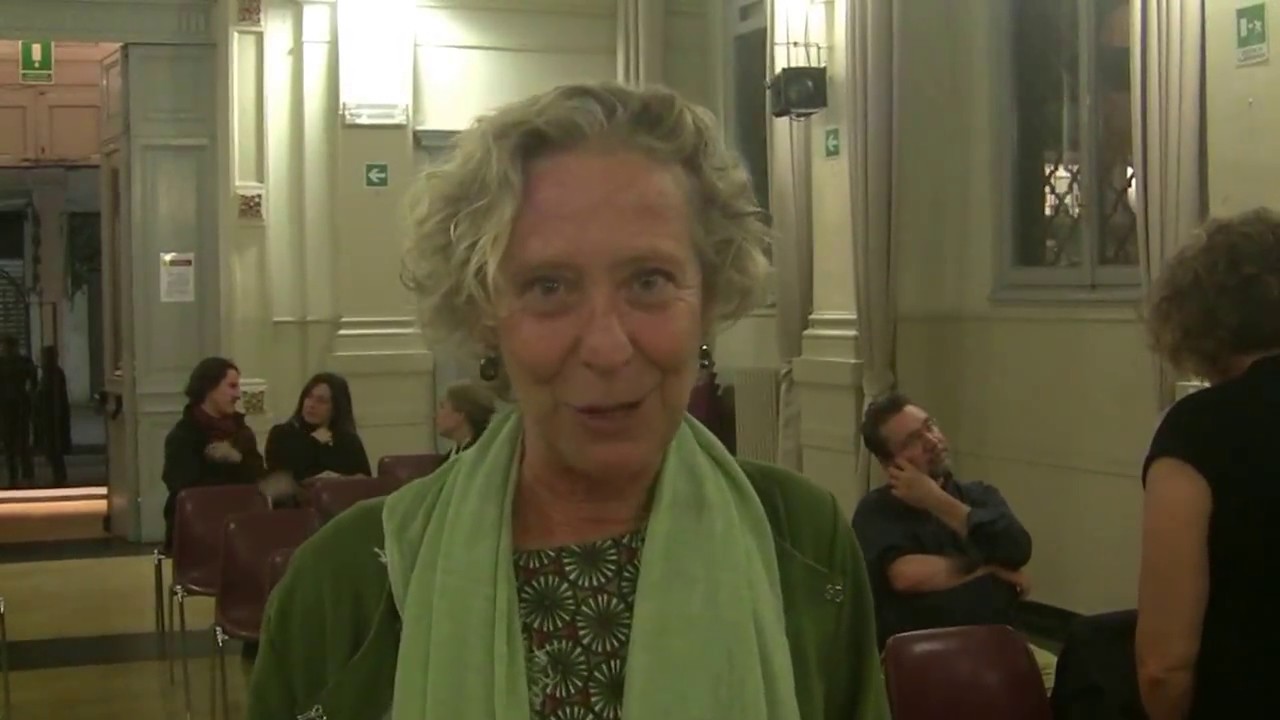Dal 1° novembre 2025, i veicoli diesel Euro 5 non potranno più circolare all’interno della ZTL Fascia Verde di Roma, una delle aree più vaste della città, che abbraccia interi quartieri, inclusi tratti significativi della periferia. Il divieto sarà in vigore dal lunedì al sabato, dalle 8:30 alle 18:30, fino al 31 marzo 2026, con esclusione dei giorni festivi. Il Comune giustifica la misura con l’obiettivo di ridurre l’inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell’aria, in linea con gli impegni ambientali nazionali ed europei. Un intento lodevole, sulla carta, ma nella realtà, questo provvedimento si presenta come una misura sproporzionata, socialmente iniqua e tecnicamente discutibile, che rischia di trasformarsi in un boomerang per la città e per i suoi abitanti. Il blocco non riguarda solo i diesel Euro 5, ma anche i veicoli a benzina fino a Euro 2, una categoria ancora molto presente soprattutto tra i cittadini meno abbienti. Il problema principale non è il principio, nessuno nega l’importanza della transizione ecologica, ma le modalità con cui viene applicato. Non è prevista alcuna deroga, nessuna gradualità, nessun sistema di compensazione o di monitoraggio personalizzato come il MoVe-In, attivo in Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto. A Roma no: la scelta è binaria, o cambi auto o stai a casa. Un approccio miope che scarica interamente il peso della transizione sulle spalle dei cittadini, senza accompagnamento, senza alternative e senza prospettive realistiche. Chi ha acquistato un diesel Euro 5 solo pochi anni fa, quando quella motorizzazione veniva ancora consigliata come “sostenibile”, si trova oggi con un’auto che rischia di diventare inutilizzabile per gran parte della settimana. Non per mancata manutenzione o obsolescenza tecnica, ma per una decisione politica assunta senza alcuna valutazione sociale. Il concetto stesso di “transizione” implica un passaggio graduale da un modello a un altro, supportato da strumenti concreti come incentivi, infrastrutture ed alternative sostenibili. In questo caso, però, si assiste a un’imposizione che non tiene conto né della realtà economica né di quella logistica della città. Il rischio evidente è quello di una mobilità a due velocità: da una parte chi può permettersi di acquistare un’auto nuova, ibrida o elettrica, continuerà a muoversi senza restrizioni, mentre dall’altra, chi non ha i mezzi per adeguarsi, lavoratori precari, pensionati e famiglie monoreddito, che si troveranno a fare i conti con limitazioni drammatiche nella gestione della vita quotidiana. La disuguaglianza sociale si estende così anche al diritto alla mobilità, trasformando una misura ambientale in un provvedimento punitivo. In un contesto come quello romano, dove i trasporti pubblici sono spesso inefficienti, affollati, soggetti a guasti e ritardi, chiedere ai cittadini di lasciare l’auto non è solo irrealistico, ma è irragionevole. I collegamenti periferici sono carenti, i parcheggi di scambio insufficienti, il servizio ferroviario metropolitano limitato, il car sharing poco diffuso nelle aree non centrali, peraltro, mancano piste ciclabili ben connesse e sicure, manca un vero sistema intermodale. Chi vive in quartieri come Tor Bella Monaca, Corviale, Primavalle o La Rustica sa bene quanto difficile sia raggiungere il centro senza l’auto. In questo scenario, vietare la circolazione senza offrire alternative credibili equivale a interrompere un servizio essenziale senza fornire un’alternativa, e come chiudere gli ospedali senza rafforzare la medicina territoriale. Il contrasto con altre regioni italiane è evidente. In Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto è attivo il sistema MoVe-In (Monitoraggio dei Veicoli Inquinanti), che permette ai cittadini con veicoli più vecchi di circolare entro un certo limite chilometrico annuale, monitorato da una scatola nera. Un sistema intelligente, che tiene conto sia dell’ambiente sia della mobilità reale delle persone, evitando esclusioni nette e irragionevoli. A Roma, invece, si sceglie la via più semplice (e più dura, più sciocca): vietare senza distinguere, senza dialogare e senza mediare. Nessuno mette in discussione l’urgenza della lotta all’inquinamento, anzi, proprio perché si tratta di un tema così importante, merita una gestione seria, competente e soprattutto equa. Ciò che si contesta è un certo “ambientalismo punitivo”, che si accontenta di fare cassa o di ottenere consensi politici veloci in nome della sostenibilità, ma senza costruire soluzioni strutturali. E, peraltro, senza affrontare i veri nodi: incentivi alla rottamazione, la riduzione delle emissioni industriali, il controllo sui riscaldamenti domestici, la pianificazione urbanistica e, soprattutto, curare gli investimenti reali sul trasporto pubblico. La vera svolta ecologica non può avvenire imponendo sacrifici a chi ha meno possibilità di sostenere i costi della modernizzazione. Serve un cambiamento di rotta, fondato su un piano di investimenti pubblici serio e trasparente per il trasporto locale; l’attivazione del sistema MoVe-In anche a Roma, con criteri flessibili e realistici; curare gli incentivi alla rottamazione con sostegni economici per l’acquisto di mezzi a basse emissioni; lo sviluppo del car sharing, bike sharing e navette ecologiche nei quartieri meno serviti, ed infine, un coinvolgimento reale dei cittadini nelle scelte strategiche, attraverso consultazioni e percorsi partecipativi. Imporre divieti senza offrire alternative è una forma di disuguaglianza mascherata da ambientalismo. Non può esserci giustizia ambientale senza giustizia sociale. Roma ha bisogno di politiche coraggiose, sì, ma anche intelligenti, inclusive e strutturate. La lotta all’inquinamento si vince con la partecipazione, non con l’imposizione, con il dialogo e non con i divieti. E, peraltro, con il rispetto delle condizioni reali di chi ogni giorno vive, lavora e si muove in una città che, oggi più che mai, ha bisogno di una vera visione del futuro.