
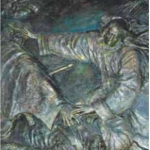
L’8 settembre 1943 dopo l’armistizio firmato dal Governo Badoglio le truppe tedesche attaccano le postazioni a difesa di Roma abbandonate dai comandi militari che avevano lasciato la truppa senza ordini e ufficiali superiori. Tra il 9 ed il 10 settembre la prima forma di resistenza in Italia all’occupazione tedesca è esplosa alla Montagnola. Soldati, popolani, protetti per quello che era possibile dai sacerdoti e dalle suore, si opposero all’avanzata delle truppe germaniche sulla Laurentina. L’8 settembre 1943, si diffonde la notizia dell’armistizio, la Montagnola è in festa, è la gioia della sospirata pace che pregusta il ritorno dei parenti militari. Alle ore 23.00 giungono i canti dei Granatieri, accampati alla macchia delle Tre Fontane. All’una di notte, in direzione dell’EUR 42 (già E42 Esposizione Universale 1942) verso il ponte della Magliana (unico attraversamento del Tevere prima di ponte di ferro alla Piramide), si alza e si estende nel cielo una vasta illuminazione di fuochi di bengala, quindi spari e raffiche ripetute, impressionanti, seguiti da mortale silenzio. Il 9 settembre 1943, Don Pierluigi Occelli detto don Pietro, parroco del Gesù Buon Pastore, esce dall’attuale canonica (ora Via Luigi Perna) e si recò alle 5 del mattino all’Istituto Gaetano Giardino al Forte Ostiense, per celebrare la Santa Messa, per le 35 suore infermiere, che assistono circa 400 orfani di guerra e minorati psichici. Mentre attraversa i campi (non esiste lo svincolo Marconi-Colombo come neanche la Marconi e la Colombo) incontrò alcuni Granatieri insanguinati e laceri per lo scontro armato della sera prima e li accompagnò alle case vicine per le medicazioni sommarie e per un pò di acqua. Un computo sommario parlò di 38 granatieri uccisi e una ventina di feriti. La popolazione si stringe a questi suoi soldati lavando ferite e vestiti ospitando nelle case i più bisognosi di soccorso, di cibo e di cure. Tra i feriti c’è anche il granatiere Daniele Grappasonni la cui famiglia viveva alla strada V (Via San Colombano). La mamma Adele era la presidente delle donne di Azione Cattolica della parrocchia. Monta il livore verso i Tedeschi. Il 10 settembre 1943 alle 5 don Pietro è di nuovo al Forte Ostiense per la solita Messa alle suore e si rende conto dello smarrimento che regna. Gli ufficiali sono quasi tutti tornati a Roma e dalle cucine si fa un’anticipata distribuzione di caffè per i soldati sfiniti per la veglia di due notti. Tra la china del Forte verso l’Ostiense, difeso dai Granatieri di Sardegna si accampano due compagnie di bersaglieri e guastatori. Inizia il bombardamento dei Tedeschi. I ragazzi, le ragazze, le suore, gli orfani, specialmente i minorati psichici e gli epilettici sono terrorizzati. Le suore pregano coi ragazzi stesi sul pavimento. Inizia l’incendio del Forte, ma la resistenza continua e si intensifica. Arrivano i paracadutisti tedeschi (“Diavoli Verdi”) ed in poco tempo hanno la meglio. La battaglia durò mezza giornata. Don Pietro, preoccupato dei 400 ragazzi, alzò un drappo bianco e trattò la resa con un ufficiale tedesco, mentre le suore Alcantarine nascondevano nei locali del guardaroba e nei magazzini il maggior numero di granatieri, per travestirli con le bluse degli inservienti e degli operai; altri vennero muniti d’improvvisati bracciali disegnati con una croce rossa di sangue. Don Pietro accompagnò alla spicciolata fuori dal forte sui campi questi improvvisati crocerossini e li mise in salvo presso le famiglie della borgata. Altri granatieri tramutati in operai usciranno a loro volta in piccoli gruppi come liberi civili. Nel frattempo, il fornaio Quirino Roscioni, mutilato della Prima Guerra Mondiale, nato a Fiastra (Macerata) il 2 dicembre del 1894, da Enrico e Carlotta Todini, negoziante (fornaio), abitante in via Farfa 41, coniugato con Candida D’Angeli e padre di cinque figli (Enrica, Nora, Roberto, Iolanda, Edda), ucciso dai tedeschi in via Vedana, davanti alla chiesa di Gesù Buon Pastore insieme con la cognata Pasqua Ercolani in D’Angelo, al tenente dei Granatieri Luigi Perna e ad altri militari, presenti la moglie e il parroco della suddetta chiesa, don Pierluigi Occelli, sepolto nel cimitero del Verano a Roma. “Quirino Roscioni, vecchio combattente e mutilato dell’altra guerra, era il fornaio della zona ed il suo negozio si trovava proprio sotto il comando dei Granatieri. Egli forniva tutte le mattine il pane ai soldati (anche il tenente Perna fu trovato che aveva nel tascapane due sfilatini freschi) ed aveva trasformato sin dalle prime ore del mattino del 10 settembre la sua casa in un fortilizio: ogni finestra aveva un granatiere col fucile spianato. Il Roscioni rimase costantemente in casa insieme con i soldati, che ubbidivano al comando di un sergente. L’ardore dell’ex combattente nel sostenere ed appoggiare i militari non venne meno se non quando, ritenuta vana ogni ulteriore resistenza contro l’invasore che aveva ormai circondata la casa e intimata la resa, fu deciso di deporre le armi. I tedeschi occuparono l’edificio e dichiararono prigionieri tanto i militari, quanto i civili. I feriti vennero incamminati verso il Divino Amore. Al Roscioni gli fu permesso, unitamente alla cognata Pasqua D’Angeli, madre di quattro figli, di recarsi presso la Chiesa, ma vennero mitragliati, alle spalle, cadendo in un lago di sangue. Nella borgata, da tempo tutti conoscevano i granatieri di stanza al Forte Ostiense e con essi avevano fraternizzato. Cosicché, quando venne la battaglia, tutte le case si trasformarono in improvvisate infermerie. Purtroppo, la metà almeno dei morti morirono dissanguati per l’assoluta carenza di cure adeguate. Anche il medico condotto del posto, il dott. Giovanni Ciccolini, era stato preso e portato dai tedeschi a curare i loro feriti. La resistenza di casa Roscioni permise un nuovo allestimento di difesa nei cinque padiglioni scolastici vicino alla chiesa, dove, dietro il muretto della cancellata, si batté eroicamente la medaglia d’oro s.ten. Luigi Perna dei Granatieri” (testimonianza di don Pierluigi Occelli, detto don Pietro, parroco di Gesù Buon Pastore alla Montagnola di San Paolo). Quella mattina aveva panificato le “ciriole” (pane tradizionale romano) per darle ai soldati italiani impegnati nei combattimenti contro i tedeschi. Nei suoi memoriali don Pietro racconta che “lo spettacolo più tragico l’ebbi sulla Laurentina, ad ogni 50 metri un carro armato nostro fumante o nero o infocato, o sventrato dai colpi dei cannoncini anticarro dei tedeschi e coppie di carristi accanto o dentro all’infocata bara, ridotti a forme di mummie in un attimo, distrutti, talvolta, sino alla riduzione ad uno scheletro”. Don Pietro ricorda anche di una popolana, oriunda abruzzese, Domenica Cecchinelli, 52 anni, madre di cinque figli, che accorse a coprire con una tovaglia il volto disfatto di un carrista e depose sul cuore bruciato un rosario. All’irrompere dei tedeschi, la donna si era rinchiusa in casa, rifiutando di riceverli e di cibarli. Le spararono attraverso il fragile uscio colpendola alle gambe, causandone la morte per dissanguamento. In canonica furono allineati i morti, nove parrocchiani e sette militari, caduti nelle vicinanze della Chiesa, che assommati ai cadaveri sparsi sul campo di battaglia, porteranno a 68 il numero dei caduti. Vinta la battaglia e occupata la Montagnola, uomini e donne insieme a due sacerdoti sono costretti a marciare con le mani in alto fino all’Acqua Acetosa e, poi, a Vallerano. È l’evacuazione forzata della borgata. I tedeschi si danno al sacco nelle case, delle cibarie, dell’oro, dei corredi da sposa, e finanche dei rami e delle conche delle umili cucine. Ai sacerdoti tolgono l’orologio e le biciclette, alle donne vigliaccamente tolsero gli orecchini, le catenelle, le spille e gli anelli. Nella casa canonica e nella chiesa verso sera, oltre ai morti e ai feriti, cercarono rifugio i popolani. Nel cuore della notte arrivano altri militari sbandati in cerca di abiti borghesi. Dopo aver esaurito il guardaroba, i sacerdoti furono costretti ad entrare nelle case lasciate vuote e rovistare nelle cassapanche dei parrocchiani assenti, dal momento che tutte le porte erano state sfondate dai tedeschi. Con assi del cantiere della chiesa, una grossa sega e dei chiodi dell’armeria dei muratori, servendosi degli ospiti notturni, vennero preparate le bare per i morti. In otto grandi casse, della capienza di due salme ciascuna, vennero composti i cadaveri. Si scavò alla meglio una vasta fossa per la sepoltura. Una suora, improvvisatasi infermiera sul campo di battaglia, suor Teresina delle Suore di Sant’Anna (Cesarina D’Angelo) affrontò in modo eroico un tedesco che rovistava tra i cadaveri dei soldati italiani in cerca di catenine d’oro. Suor Teresina si lanciò sul predatore, colpendolo in fronte con il crocefisso d’ottone e, non fermandosi neanche davanti alla minaccia del mitra che le aveva puntato al viso, lo costrinse a desistere. Suor Teresina, nel prosieguo della battaglia, cercando i feriti, rimase colpita e, dopo tre mesi, per le gravi ferite riportate, morì. In quei giorni, don Pietro Occelli formò e costituì la prima banda partigiana cristiana antisabotaggio “Avogadro degli Azzoni”, forte di 80 giovani, per lo più provenienti dall’Associazione “Piergiorgio Frassati” (Azione Cattolica) collegata al Comitato di liberazione nazionale capitolino tramite monsignor Roberto Ronca, rettore del Seminario Romano dove si nascondeva l’élite dell’antifascismo italiano (De Gasperi, Nenni, Saragat e Bonomi), operante in tre gruppi: alla Montagnola, alla Collina Volpi e al Testaccio, comandata dal generale Rodolfo Cortellessa. Quattro giovani pallottini della parrocchia, li assistevano come ufficiali. Don Pierluigi Occelli detto don Pietro, “un prete ed un uomo non qualunque”, così sono state definite la vita e le opere, nasce a Busca (CN) il 21 novembre del 1903, laureato in Legge all’Università di Torino divenne sacerdote della Società San Paolo, per la quale fu tra gli ideatori di Famiglia Cristiana, insieme con lo storico fondatore don Giacomo Alberione, e che diresse nel 1933 e ’34. Le grotte, a due ordini sottostanti la Chiesa, saranno depositarie di un vero arsenale di “91” si riferisce al fucile Carcano Mod. 91, un’arma da fuoco a otturatore girevole-scorrevole adottata dal Regio Esercito italiano a partire dal 1891, mitra, baionette e varie cassette di bombe a mano, disposte in ordine e rosseggianti, come lucentissime mele, nelle casse dal timbro di fabbrica: “Cera da Chiesa – Miralanza (Genova)” è stata una storica azienda italiana che produceva candele steariche, saponi e detersivi. Cinque ragazzi, una volta a settimana, scendevano nelle grotte per dare il grasso alle armi. Questo storico momento descrive in modo dettagliato e toccante i drammatici eventi dall’8 al 10 settembre del 1943, durante l’occupazione tedesca di Roma. Questi momenti cruciali segnano l’inizio della resistenza italiana contro le forze occupanti, illustrando sia il coraggio degli uomini e delle donne comuni, sia la sofferenza e il caos che attraversavano la città. In particolare, i racconti di Don Pietro Occelli offrono uno sguardo sulla vita quotidiana in un contesto di guerra e devastazione. La sua dedizione nel prendersi cura dei feriti e nel cercare di proteggere i più vulnerabili, come i bambini orfani e i minorati psichici, evidenziano l’umanità e la solidarietà che possono emergere anche nei momenti più bui. Il sacrificio di cittadini come Quirino Roscioni, che cercarono di opporsi ai tedeschi pur rischiando la vita, aggiunge ulteriori strati di eroismo e disperazione alla narrazione. Inoltre, le immagini vivide dei combattimenti, delle perdite e delle distruzioni, unite ai sentimenti di paura e smarrimento dei civili, contribuiscono a far comprendere la gravità di quel periodo storico. Queste testimonianze sono importanti non solo per ricordare gli eventi storici, ma anche per riflettere sulle esperienze umane durante la guerra. Il racconto di Don Pietro è intriso di umanità e dolore, un affresco straziante delle atrocità subite dalla popolazione durante l’occupazione nazista. La figura di Domenica Cecchinelli emerge come simbolo di coraggio e dedizione, rappresentando le donne che, in circostanze estreme, hanno mostrato un grande spirito di sacrificio. La sua decisione di coprire il volto di un carrista morto con una tovaglia e di deporre un rosario sul suo cuore bruciato è un gesto di profonda pietà e rispetto, e la sua tragica morte per mano dei soldati tedeschi evidenzia la brutalità della guerra e la vulnerabilità dei civili. La storia di Romolo Dorinzi è un esempio straordinario di coraggio e determinazione in un momento di grande pericolo. A soli 14 anni, ha dimostrato una prontezza di spirito notevole, scegliendo di mettere a rischio la propria vita per informare i granatieri della minaccia imminente rappresentata dai paracadutisti tedeschi. La scena in cui Romolo si libera dalla presa della madre per correre verso il Forte è carica di emozione. La disperazione di una madre che cerca di proteggere i propri figli contrasta con l’eroismo istintivo del ragazzo, che, pur comprendendo il pericolo, decide di agire per il bene della comunità. Il suo coraggio nello zigzagare tra i proiettili, nonostante venga ferito, evidenzia la sua determinazione e la capacità di superare la paura. Arrivare tra i granatieri e dare l’allerta fa di Romolo un eroe, non solo per il suo gesto, ma anche perché ha saputo mettere da parte il proprio istinto di autoconservazione per salvare vite. La sua azione ha avuto ripercussioni significative, evitando una potenziale strage. Oggi, Romolo Dorinzi porta con sé non solo il peso dei ricordi di quegli eventi drammatici, ma anche la saggezza accumulata nel corso di una vita. La sua figura, alta e robusta, con i capelli bianchi, è testimonianza di come l’innocenza giovanile possa trasformarsi in resilienza e forza nel tempo. La narrazione degli eventi seguenti, che includono l’evacuazione forzata della borgata e saccheggi brutali, mette in luce la disperazione e la perdita che caratterizzavano quel periodo. Anche la figura di suor Teresina risalta come esempio straordinario di coraggio. La sua audace azione nel proteggere i morti da un soldato tedesco è emblematicamente un atto di sfida e resistenza. La sua morte successiva a causa delle ferite subite sottolinea la devastazione che ha colpito molti, compresi coloro che cercavano solo di aiutare gli altri. In questo contesto di sofferenza e lotta, la creazione della banda partigiana cristiana antisabotaggio “Avogadro degli Azzoni” e l’impegno di Don Pietro come leader e organizzatore evidenziano la risposta della comunità di fronte all’oppressione. La sua formazione e la sua storia, insieme a quelle dei giovani coinvolti, rappresentano speranza e determinazione nella lotta contro il regime oppressivo. L’immagine delle grotte sotto la chiesa, adibite a deposito di armi, simboleggia il nascente movimento di resistenza, pronto a combattere per la libertà. È toccante pensare a questi ragazzi che, nonostante i rischi, si dedicano alla manutenzione delle armi, pronti a rispondere alla chiamata. La testimonianza di Don Pietro Occelli, con i suoi dettagli vividi e le storie di vita e morte, resta un monito sulla resilienza dello spirito umano e sull’importanza di ricordare e onorare coloro che hanno lottato per la libertà e la dignità in tempi di oscurità.
