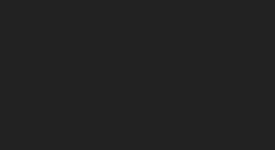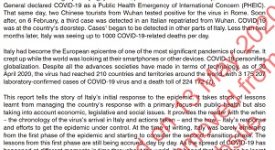Ogni giorno ci lamentiamo del traffico, dei clacson, del cantiere sotto casa e delle sirene che attraversano la notte, ma raramente ci chiediamo se tutto questo rumore abbia un prezzo. Eppure ce l’ha, ed è alto. L’inquinamento acustico, definito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come “rumore ambientale dannoso per la salute umana”, non è solo una seccatura urbana. È un fattore di rischio per la salute pubblica, una fonte di diseguaglianza ambientale e una minaccia per molte specie animali. Tuttavia, nelle agende politiche e nel dibattito pubblico, continua a restare un tema marginale. Secondo l’Agenzia Europea dell’Ambiente, oltre 113 milioni di cittadini europei sono esposti quotidianamente a livelli di rumore superiori ai 55 decibel, la soglia oltre la quale il rischio per la salute aumenta. Solo in Europa, si calcolano più di 12.000 morti premature all’anno attribuibili al rumore ambientale, e un milione di anni di vita sana persi. Peraltro, l’inquinamento acustico è ancora trattato come un “male necessario” ed un effetto collaterale dello sviluppo urbano. Forse perché non lo vediamo, non lo respiriamo e non lo tocchiamo, ma lo subiamo, costantemente. Il primo fraintendimento da superare è che il rumore sia solo fastidio. In realtà, l’esposizione cronica al rumore, anche a livelli moderati, produce effetti fisiologici misurabili: aumento della pressione sanguigna, disturbi del sonno, alterazione del battito cardiaco, maggiore produzione di cortisolo ed altri ormoni dello stress. Una ricerca pubblicata su The Lancet ha collegato l’inquinamento acustico ad un aumento del rischio di infarto nelle persone che vivono in prossimità di arterie stradali o aeroporti. Nei bambini, il rumore ambientale influenza l’apprendimento, la concentrazione e lo sviluppo del linguaggio. Non è un caso che l’O.M.S. abbia inserito il rumore tra i principali fattori ambientali di rischio per la salute nei Paesi occidentali, dopo l’inquinamento atmosferico. A differenza di altri inquinanti, però, il rumore non ha soglie evidenti: non si accumula nel corpo e non dà sintomi immediati. Agisce lentamente, come un logorio. E proprio per questo è spesso sottovalutato. Come ogni forma di inquinamento, anche quello acustico colpisce in modo diseguale. I quartieri più esposti al rumore sono spesso quelli dove vivono le classi sociali più fragili: aree vicine a infrastrutture, zone industriali o strade ad alta percorrenza. Nel centro di una grande città, chi può permettersi di vivere in una via pedonale o in una casa con doppi vetri non subirà gli stessi effetti di chi abita al quarto piano di un palazzo affacciato su una tangenziale. Anche il rumore, peraltro, è un indicatore di povertà ambientale. È una dinamica che si ripete ovunque nelle periferie urbane, nelle città portuali e nei pressi delle ferrovie. Spesso riguarda anche le scuole e gli ospedali, cioè i luoghi dove il silenzio dovrebbe essere garantito. Anche gli animali subiscono gli effetti dell’inquinamento acustico e in molti casi, in modo più drastico degli esseri umani. Infatti, gli uccelli che vivono in città cambiano i propri canti, modificandone frequenza e durata, per riuscire a comunicare sopra il rumore del traffico. I pipistrelli, che si orientano tramite eco localizzazione, possono essere completamente disorientati dal rumore di fondo urbano. Gli animali marini, in particolare i cetacei, sono minacciati dal traffico navale e dalle esplosioni sottomarine utilizzate per l’esplorazione di idrocarburi. Il rumore altera i comportamenti migratori, la riproduzione e la predazione. E si aggiunge ad altri fattori di stress come l’inquinamento chimico, la perdita di habitat e il riscaldamento globale. L’impatto del rumore sulla biodiversità è ampiamente documentato, ma ancora scarsamente riconosciuto nelle politiche di tutela ambientale. A livello europeo, esiste una direttiva (2002/49/CE) che impone agli Stati membri di redigere mappe acustiche e piani d’azione per ridurre il rumore nelle aree urbane. In Italia, la legge quadro 447/1995 ha posto le basi per una normativa sul rumore ambientale, ma nella pratica, l’applicazione è stata lacunosa e disomogenea. Infatti, molti Comuni non hanno mai approvato un piano acustico comunale. I controlli sulle emissioni sonore affidati ad ARPA delle attività produttive e commerciali sono sporadici, e, spesso, sottofinanziate. Le sanzioni sono rare e poco dissuasive. E la percezione pubblica del problema resta bassa: protestiamo contro la spazzatura nelle strade, ma accettiamo il rumore come un sottofondo inevitabile. Il risultato è un’assenza di strategia nazionale. Manca un coordinamento tra Enti, una visione di lungo termine e, soprattutto, una volontà politica di affrontare il problema con serietà. Le soluzioni esistono, e sono già sperimentate in molte città europee. Barriere acustiche naturali (alberi, siepi, terrazzamenti); pavimentazioni fonoassorbenti nelle strade; zonizzazione del rumore limitando gli orari per cantieri e attività commerciali; regolamentazione degli impianti audio nei locali pubblici; incentivi per mezzi di trasporto elettrici e silenziosi e progettazione urbanistica orientata alla quiet city: meno auto, più aree pedonali, spazi verdi e piste ciclabili. Non è solo una questione tecnica. Serve un cambio culturale: rieducare cittadini, amministratori, architetti e imprese al valore del silenzio. Inserire il tema del rumore nei programmi scolastici. Usare campagne pubbliche per aumentare la consapevolezza. Perché il rumore è una forma di degrado, come i graffiti vandalici o i rifiuti in strada. Solo che si sente, ma non si vede. In un’epoca in cui si parla molto di sostenibilità, è paradossale che si parli così poco di inquinamento acustico. Forse perché è difficile farlo diventare un tema di mobilitazione politica. Nessuno scende in piazza per chiedere più silenzio. Eppure, il rumore incide sulla qualità della vita quanto (se non più) di altri fattori. Chi ha vissuto in una città senza traffico lo sa: il silenzio non è un lusso, è un diritto. Recuperare il valore politico del silenzio significa cambiare modello urbano, economico e culturale. Ciò significa riconoscere che la salute mentale è tanto importante quanto l’efficienza della mobilità e che un ambiente più silenzioso è anche un ambiente più sano, equo e vivibile.