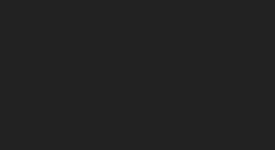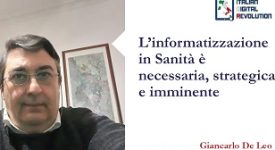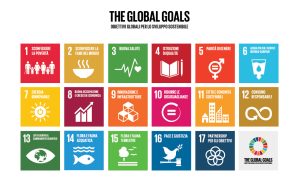
Mentre il dibattito pubblico si polarizza tra sostenitori entusiasti del progresso sostenibile e scettici bollati frettolosamente come “complottisti”, il mondo avanza, spesso senza che i cittadini abbiano piena consapevolezza di cosa accada davvero dietro le grandi etichette della modernità: Agenda 2030, transizione ecologica, città da 15 minuti, auto elettrica, cibo sostenibile. Sono termini entrati nel linguaggio politico e mediatico con un alone di inevitabilità e desiderabilità, ma che meritano di essere analizzati con attenzione, andando oltre la superficie e le narrazioni preconfezionate. L’Agenda 2030, sottoscritta nel 2015 da 193 Paesi membri dell’ONU, è presentata come un piano d’azione globale per sradicare la povertà, promuovere l’uguaglianza e proteggere il pianeta attraverso 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs). Una visione apparentemente nobile e condivisibile, che però rimane, di fatto, un insieme di linee guida non vincolanti, spesso adottate più per forma che per sostanza. Il rischio concreto non è tanto un complotto globale quanto una deriva fatta di greenwashing, dove governi e multinazionali si appropriano del linguaggio della sostenibilità per giustificare politiche poco trasparenti o economicamente discutibili. Nel cuore di questa visione si inserisce il concetto delle “città da 15 minuti”, un modello urbano nato in Francia che mira a riorganizzare gli spazi in modo che ogni cittadino possa vivere, lavorare, curarsi, studiare e fare acquisti a non più di un quarto d’ora a piedi o in bicicletta da casa. Anche in questo caso, l’intento dichiarato è quello di ridurre traffico, inquinamento e stress, promuovendo una vita più locale e sostenibile. Ma se in teoria l’idea sembra virtuosa, nella pratica potrebbe facilmente degenerare in strumenti di controllo sociale e restrizione della mobilità, soprattutto in mano a governi autoritari o amministrazioni poco democratiche. Non è una fantasia distopica immaginare che l’infrastruttura pensata per migliorare la qualità della vita possa diventare un meccanismo di sorveglianza e segmentazione urbana. Il tema del controllo sociale, del resto, non è più un tabù, almeno in alcune parti del mondo. La Cina ha già implementato un sistema di “credito sociale” che premia o penalizza i comportamenti dei cittadini in base alla loro condotta. E durante la pandemia da Covid-19, anche in Occidente, si sono viste misure emergenziali inedite, come il tracciamento digitale, le certificazioni sanitarie obbligatorie e restrizioni di movimento mai viste in tempo di pace. Strumenti che, pur giustificati dal contesto sanitario, hanno aperto un precedente importante e mostrato quanto rapidamente sia possibile ridurre diritti e libertà civili in nome della sicurezza collettiva. Pensare che simili strumenti non possano essere riutilizzati in futuro, magari in nome della “salute del pianeta”, sarebbe ingenuo. La transizione ecologica, altro pilastro dell’Agenda 2030, solleva a sua volta questioni complesse. L’auto elettrica, ad esempio, è spesso presentata come la panacea per l’inquinamento urbano, ma in realtà comporta costi ambientali e sociali altissimi legati all’estrazione e allo smaltimento delle batterie. Il litio, il cobalto e il nichel necessari alla produzione provengono spesso da miniere in Paesi poveri, dove i diritti umani sono sistematicamente violati. Allo stesso modo, la corsa alla diffusione di pannelli solari e pale eoliche sta generando nuove forme di colonizzazione del territorio: si sacrificano ettari di terra agricola in nome di una “sostenibilità” che, paradossalmente, compromette la sicurezza alimentare e il lavoro degli agricoltori. Anche il cibo non sfugge a questa rivoluzione verde. Le proteine alternative, come gli insetti, sono promosse come risposta sostenibile alla crisi climatica e al sovrappopolamento. Nessuno impone (per ora) di mangiarli, ma la pressione mediatica e istituzionale inizia a farsi sentire. Mentre gli allevamenti tradizionali vengono demonizzati per l’impatto ambientale, si finanziano produzioni industriali in laboratorio che spostano l’alimentazione da un modello naturale a uno sintetico, gestito da poche grandi aziende biotecnologiche. La gestione della pandemia ha rappresentato un banco di prova per molti di questi strumenti. Dalla “vigile attesa” in Italia alla narrazione mediatica univoca, fino al ricorso al vaccino come unica via possibile, si è assistito a una compressione del dibattito e delle libertà individuali che ha lasciato strascichi profondi nella fiducia collettiva. Parlare di una prova generale di controllo globale è eccessivo, ma ignorare le implicazioni democratiche di quanto accaduto sarebbe irresponsabile. La sfiducia crescente nelle istituzioni non è sempre frutto di ignoranza o irrazionalità: spesso è il risultato diretto di scelte opache, incoerenti o imposte dall’alto senza coinvolgimento reale dei cittadini. In definitiva, la vera domanda non è se ci sia un piano segreto per controllare la popolazione. La domanda è: quanto potere siamo disposti a cedere, in cambio di sicurezza, comodità e sostenibilità apparente? E soprattutto, chi sta davvero beneficiando di questi cambiamenti, e chi ne paga il prezzo?